L'ho detto io che ci piovono favole infinite ?
Questa è una particolare. E' uno scrittore e ho dovuto fare delle puntate perchè da quando gli ho detto di scrivere per noi, ci si è buttato a capofitto.
Grazie infinite Umberto, è un piacere leggere queste righe !

Un bel giorno, in tarda mattinata, arrivai a Belgrado e all’aereoporto noleggiai un auto.
Era il luglio del 2005, cuore di una bella estate che arrivava dopo il gran caldo di quelle degli anni precedenti.
Avevo deciso di girare alla ricerca dei monasteri ortodossi, fondamenta della chiesa autocefala serba. Alla ricerca di leggende e segreti che ormai da secoli custodivano.
Senza passare per Belgrado imboccai la E75 in direzione sud-est, verso Nis.
Avevo già in mente le destinazioni che avevo evidenziato sulla carta stradale con dei cerchi rossi, per non perderle mai.
La cittadina di Despotovac, lungo il corso di un piccolo fiume chiamato Resava, sarebbe stata la mia prima tappa. Da lì, a cavallo tra quello stesso giorno e il successivo, sarei riuscito tranquillamente a visitare Manasija e Ravanica.

Dopo un’ora e mezza di viaggio, comprensiva di un veloce pranzo consumato in un piccolo grill lungo la strada, giunsi al bivio e da lì, in alcune decine di minuti, fui ad un tiro di schioppo da Despotovac. Trovai alloggio per la notte all’hotel Kruna, un civettuolo motel “ontheroad” che mi sento di consigliare per l’accogliente ospitalità.

Il monastero di Manasija, anticamente chiamato Resavica proprio per la vicinanza del fiume, sorge a pochissimi chilometri dal paese, là dove la pianura comincia ad innalzarsi fino a formare alture collinose non elevate ma certamente evidenti.
Man mano che mi avvicinavo con l’auto, la fortezza sorgeva tra la folta vegetazione delle alture e cominciava a stagliarsi sull’orizzonte alla mia destra. Gli alberi la nascondevano alla mia vista, facendola comparire e scomparire come in un puzzle cui venivano aggiunte tessere e poi tolte. Quindi una serie di curve in salita, e poi il sentiero, sotto le imponenti mura e le possenti torri. Undici torri di pietra.

Là, incuneato tra verdi colline ondeggianti, nascosto oltre le sue stesse mura, eccolo apparire aldilà del massiccio arco d’ingresso fregiato delle immagini di arcangeli che lo presentano al viandante. Tra aiuole di rose rosse curate da mani sapienti, ecco il monastero.
I segni del tempo, chiaramente manifesti sulla cinta muraria, sembravano invece non aver nemmeno sfiorato quel gioiello d’arte e di storia, che se ne stava accovacciato nel suo nido di pietra e di fiori.
Fatto edificare da Stefan Lazarevic, figlio del principe Lazar Hrèbljanovic, il monastero mi mostrò all’interno i suoi santi guerrieri, difensori della fede, affrescati sulle pareti. L’antica bellezza era pari al timore che incutevano. Li ammirai per la prima volta nella vita. Dall’alto sembravano ammonire a non violare le sacre fondamenta e la sacralità di un luogo nato per preservare i misteri.

E poi l’affresco dello stesso zar Lazarevic che offre il suo monastero a Dio, tradizionale immagine che avrei trovato in tutti quelli che avrei visitato di lì a pochi giorni.
Portava in braccio la chiesa come fosse un bambino. Come si fa con la propria creatura.
Fuori il cielo era azzurro, appena velato di nuvole. E il silenzio incombeva come una coltre di nebbia. Anche i passi di un monaco vestito di nero che attraversava il giardino sembravano sparire nell’assoluta assenza di rumori.
Mi guardai attorno, e il mio sguardo andò alto, cercando di scavalcare le mura. Mi sentivo protetto. Mi sentivo al sicuro nella fortezza di Manasija. Il senso di inespugnabilità non era solo riferito alla fede ma anche all’isolamento che i bastioni riuscivano a offrirmi. Era così da sempre, da oltre 600 anni. Tutt’attorno solo il verde scuro di inestricabili boschi.
Il giardiniere che mi passò accanto mentre, seduto all’aria aperta, cercavo di assaporare il mio stesso respiro, mi salutò con le tre dita alzate, simbolo dell’unità serba. Dio, re e patria. E allo stesso modo istintivamente risposi.
Nel tardo pomeriggio, dopo un breve giro per le strade di Despotovac, tranquilla cittadina con bambini che giocavano per la strada e donne che facevano la spesa, rientrai in hotel.
La proprietaria, una giovane donna allegra e decisa, mi preparò la cena. Un bisteccone, o meglio un hamburger. Pljeskavica, con patate, carote e cipolle tutte tritate a pezzettini.
E mi offrì una sljivovica, dal colore giallo come l’oro. Mi raccontò che era preparata da suo padre, meticoloso realizzatore dell’antica ricetta.
L’indomani, prima che io lasciassi l’hotel, mi accompagnò nel retro e me lo presentò, suo padre. Gli esternò i miei complimenti per l’ottima grappa di prugne. Lui ringraziò, con dignità e un sorriso negli occhi.
Mi avviai alla ricerca del monastero di Ravanica, quello che da sempre aveva in me esercitato il fascino maggiore. Tra le sue mura era custodito il feretro con le spoglie mortali dello Knèz Lazar, l’eroe fatto santo da cui avevano preso origine l’epopea e il mito di Kosovo Polje. Una battaglia che è da considerarsi lo spartiacque tra la Serbia antica e quella moderna. Il martirio di un uomo era tornato ad essere, così come lo era stato quello del Cristo, simbolo di salvezza. Il simbolo di una scelta. Quella tra la gloria terrena e quella celeste. E Lazar Hrebljanovic aveva scelto quest’ultima. Avevo letto di storie e leggende nello stupendo resoconto che Rebecca West aveva scritto del suo peregrinare attraverso la Jugoslavia degli anni trenta. E il mito di Sv.Lazar mi aveva colpito.
.BMP)
La strada verso Ravanica fu tortuosa, e la mia meta sembrava non arrivare mai. Sulla carta stradale il percorso mi era apparso più breve, ma forse le numerose curve e l’apparire di piccoli paesi nemmeno indicati lo resero infinito. Quando mi fermavo per chiedere a qualcuno se la mia direzione fosse giusta, annuivano col capo e m’incoraggiavano ad andare avanti «Manastir Ravanice? Pravo, samo pravo»
Una tipicità dei monasteri ortodossi, nati ai tempi del dominio ottomano per difendere la fede cristiana, era proprio quella di non apparire alla vista dell’uomo. Per trovarli bisognava cercarli attentamente, e solo allora, forse, sarebbe stato più semplice trovarli.
Avevo imparato questa lezione qualche anno prima in Bulgaria. Un monaco del monastero di Rila mi aveva raccontato che questi baluardi della fede nascevano proprio tra le montagne per crescere nascosti agli occhi del mondo. E a quelli degli invasori.
Non lo scorgevo ancora, eppure ero certo che ormai dovesse apparire ai miei occhi da un momento all’altro. Era come se girassi attorno alla mia coda senza riuscire ad afferrarla.
Accostai ai margini della strada per l’ennesima volta, sperando fosse l’ultima, e alla mia richiesta d’informazioni l’anziana signora scoppiò in una genuina risata. Con l’indice della mano destra mi fece un chiaro segnale. Il monastero stava là, alla mia sinistra. Bastava voltarsi e guardare.
Stava là, come sbucato dal nulla. La strada declinava leggermente e si immetteva in una spianata d’erba brillante per la luce del sole.
Entrai, e dopo aver parcheggiato varcai l’arco d’ingresso.
Ciò che mi colpì all’istante fu l’imponenza di quella costruzione, i cui colori variavano armonicamente dal bianco al rosa denso, e la facciata di pietra variopinta ai piedi della quale si apriva la porta principale. Essa sembrava un blocco a sè stante.
Trattenni il fiato. Stavo per entrare e trovarmi al cospetto del principe Lazar. Stavo per spalancare i miei occhi sulla battaglia di Kosovo Polje.
Alla destra dell’altare, ricoperto dalla bandiera serba, stava la tomba dell’uomo che aveva cambiato per sempre la storia del suo paese. La sua sconfitta sul campo di battaglia avrebbe impresso per sempre sulla leggenda il marchio del martirio.
Restai assorto per diversi minuti, come cercando di mettermi in contatto con quell’uomo sulle cui vicende avevo letto tanto. Non c’era nessuno attorno a me, soltanto alcune suore che girovagavano entrando e uscendo dal tempio. Sono questi i momenti in cui si assapora l’eternità. Quelli che nascono quando ci si trova di fronte ad un mito, leggendario o reale che sia. Poi uscii anch’io e iniziai a vagare attorno al monastero. Anche qui, come a Manasja, il tempo sembrava non far parte del tutto. Bastava immedesimarsi soltanto un po’ per sentir scorrere addosso i segni di un mondo lontano.

Una donna, che parlava benissimo l’inglese e che mi disse di essere una studiosa, uscì sorridente dagli alloggi dei monaci e insistette per scattarmi una foto. Insistette tanto che alla fine glielo consentii. E la resi felice. Poi mi avviai all’auto e ripartii alla volta di Nis. Da lì, dopo un paio di giorni avrei ripreso la strada verso Studenica....
Continua
quiUmberto Li Gioi.

























.BMP)



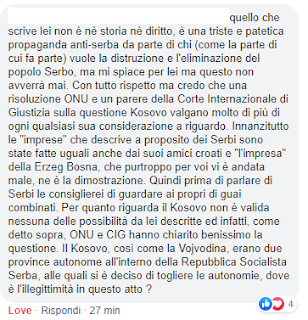



.jpg)

